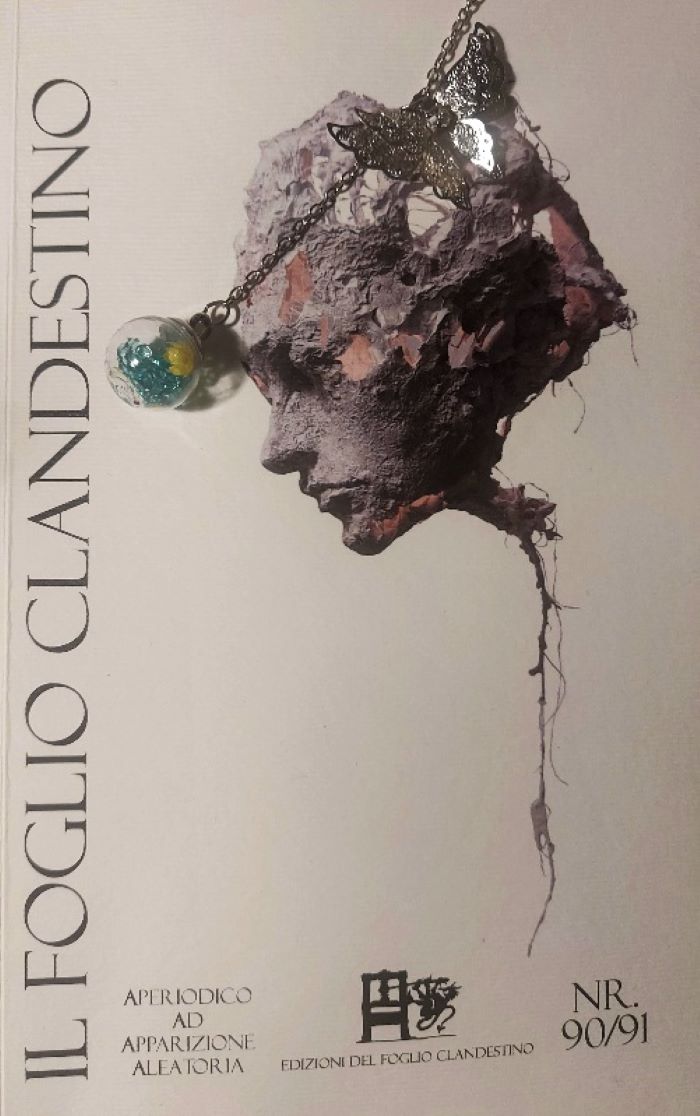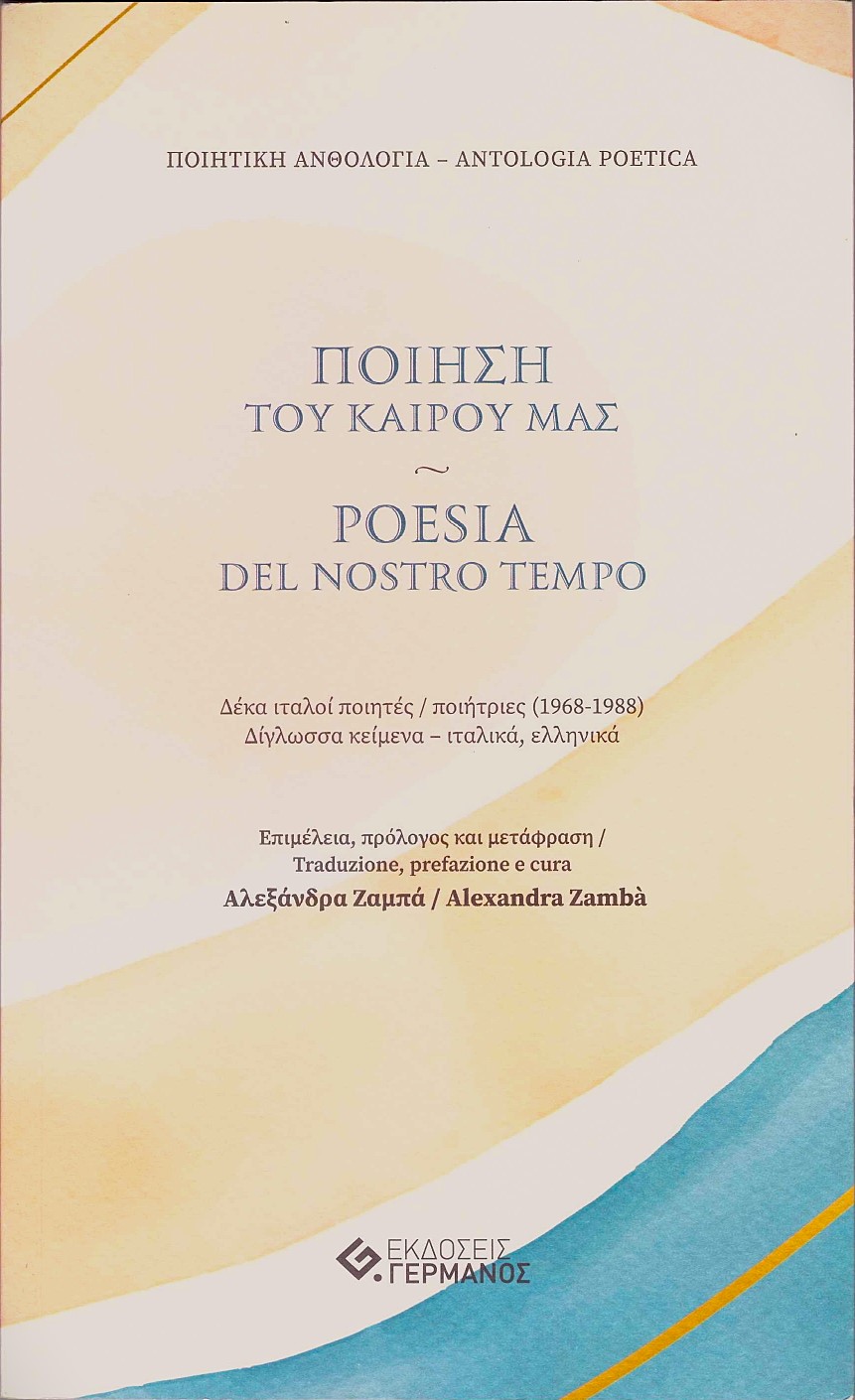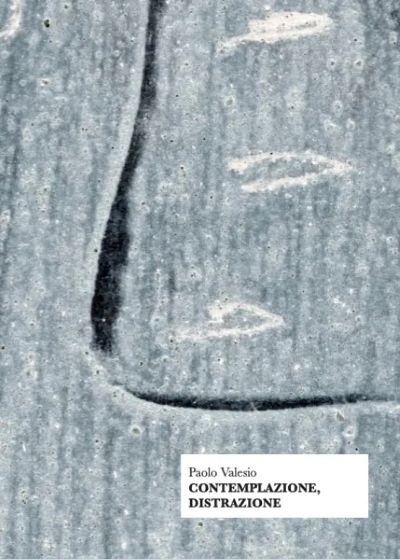a cura di Rosanna Frattaruolo
Lettera alla madre
Talvolta sogno e spero
che mia madre venga a prendermi
e mi riporti da dove sono venuto.
Possa mondarmi delle colpe
reali e ascritte, dei desideri egoisti.
Lei conosce la strada. Vorrei solo
la percorresse all’incontrario.
Vorrei rivederla all’intersezione dei sentieri,
dove spesso ho incontrato il suo sguardo.
Quelle mute carrarecce che solcano
campi e pratoni vallivi, tra lame d’oro
e polvere dai pioppi, tra coni ombreggianti
dai pini e aprirsi d’azzurro nel cielo.
Dove le parole cadono come stracci di neve
e spogliati di pensieri ci si parla
con sguardi sommessi e gesti trattenuti.
La terza pagina, dov’è l’inizio.
L’inizio quando il mondo era colore e quadro.
Il liquefarsi del ricordo in rivoli di luce.
Il viaggio, solo quello chiedo.
Lei lo iniziò, lo svolse in parte, mi diede
un biglietto per proseguirlo. Saprà di certo
come finirlo o riavvolgerlo. E forse
anch’io lo so: la vedrò arrivare in bicicletta,
col suo sorriso di ragazza, mi guarderà
come se non sapesse chi sono.
La guarderò sapendo ch’è troppo giovane
per essere mia madre, ma lo sarà.
Sarò io troppo vecchio per lei.
Saranno tutti gli anni passati, tutti quelli
che voleva per me, senza suoi segni
o presenze, se non quelle conficcate nel cuore.
Lei sa quanti lacci mi legano,
con quanta fatica abbia cercato di scioglierli,
senza mai riuscirci del tutto. Le presenze
del passato e le unghie dei morti ritornano,
come i riti contadini e il sangue nelle corti.
Lei fu la mia traduzione al mondo,
all’universo avverso familiare,
alla sua prepotenza. Mi diede parole
che non conoscevo e gambe veloci.
Vorrei mi portasse a chiedere scusa
a chi ho involontariamente offeso,
agli altri no, che offesi devono stare.
Vorrei essere ancora figlio e padre.
Alla fine questo sono stato,
nello stesso tempo, negli odori asettici
di ospedali e cure domiciliari. Là nessuno
si curava di me. Ci sono dolori che
non hanno poesia, non sulla crosta del mondo.
Fu lei ad insegnarmi che i ‘forti’ sono forti
solo fino a quando i ‘deboli’ resistono.
*
Lettera al padre
Non ti detesto tanto quanto
potrebbe sembrare. Salvo di te
qualche parte innocente, pulita.
Salvo l’esserti sentito tronco
e roccia per tanti e non per noi.
Salvo la tua onestà, il rigore
pignolo e peloso, lo stesso
con cui aggiustavi serramenti e infissi,
riparavi oggetti comuni e coscienza.
Anche me hai provato ad aggiustare.
Sapendo ch’ero refrattario e che tu
mi eri mancato e mi manchi.
A te non sono mai mancato abbastanza.
Salvo le assenze, nei cui anfratti
cercavo luoghi per proteggermi.
Salvo il passo ostinato, metodico,
disciplinato con cui salivi i monti,
lo stesso con cui salgo anch’io.
Salvo le certezze che ti hanno salvato.
Salvo la facilità senile alle lacrime
che oggi è la mia. Salvo l’avermi avuto
come figlio di sangue, eppure adottivo.
Salvo il considerare tutto sbagliato
se non si adegua ai canoni appresi.
Salvo le piogge timide, sommesse,
che non furono tue. Le piogge d’aprile.
Il mese che avrei voluto e non fu.
Salvo l’avermi preteso a forza
e non aver cercato il capo della matassa.
Il groviglio dei budelli che dicevano
di non ammettere secondi errori.
Salvo la scontentezza. L’essere piagato
da un diciassettenne borioso e timido,
dalle evenienze di una vita familiare
che volevi lineare e lineare non era.
Salvo lo spaesamento di un dopoguerra
inoltrato e ostile. Salvo le sfuriate
con mio fratello, che ti tenevano
lontano da me. Lui avrà apprezzato
le poche che mi prendevano a bersaglio.
Salvo i canti delle mondine
e le romanze d’opera. Salvo
l’entroterra, da cui a piene mani
hai raccolto povertà e riscatto.
Salvo le liturgie contadine, che tu,
inurbato e indifeso, forse non hai salvato.
Salvo le feste comuniste campagnole,
quelle a cui mi hai portato,
allontanandoti in fretta
per un diverso destino del vivere.
Io ci sono rimasto ancorato
come fossero sempre la radice voluta.
La vita che spezza e divide il pane,
il pane che volevi in tavola e imponevi,
quasi eucaristia pagana.
Salvo il sentore di ferro e tintura di iodio.
Salvo le cure, malamente espresse,
che ho avuto per te, che così poche
ne avesti per me, eppure credesti
di avermele date, perché materia,
soldo e dannazione delle tue fedi.
Non riuscivo a sottovalutare i premi,
le gratificazioni. Tu certo potevi,
dal lato nero dell’essere adulto.
Tra maschi, però, i riconoscimenti
non sono una faccenda secondaria.
Di quello vivono, tra loro.
Salvo le aritmie delle ultime ore,
le montagne russe dei tracciati,
i tentativi estremi dei medici,
mio fratello che ci apostrofa orfani,
la telefonata, tentata e negata, a mio figlio
per dare e ricevere conforto.
Per tutto questo e altro ancora
il dio dei figli ti salva e assolve e perdona.
*
Lettera al figlio
Ti lascerò la mia libreria, figlio caro.
La letteratura che ho letto. Di scienza
ne ho masticata poca. Giusto quella
necessaria a terminare l’università,
e che così poco è servita.
Io sono la letteratura che ho letto.
Se ti lascio i miei libri,
ti lascio intero me stesso.
Anche la musica è per te, la musica
che sempre ho cercato,
che non inganna con inutili parole,
spesso ambigue, interpretabili
in cento modi diversi, dissimulatrici.
La malinconia sarà un altro dono,
parte di me per vie genetiche e amniotiche,
per imperscrutabili strade del destino.
Ti lascio tutto l’amore che non sempre
sono riuscito a darti e meno ancora a dirti,
perché mi sei mancato e l’assenza
è dolore, ferita. I figli vanno,
com’è naturale, senza sapere i vuoti,
non presumono l’irripetibilità del tempo,
l’unicità delle occasioni. Vorrei soltanto
un’ultima passeggiata in un bosco,
io e te soli. Chissà!
Resterò, spero sempre, nel tuo cuore,
almeno finché resterà il tuo cuore.
Dopo, credo, non avrò luogo
in cui emigrare. E sarà quello il giorno
in cui morirò davvero.
Dalla prefazione di Alberto Bertoni.
Enrico Trebbi non solo è un uomo, ma anche un poeta di parola. Perciò, se intitola E cosí sia il suo nuovo libro di poesie vuol dire – da una parte – che il suo percorso di autore “a stampa” deve considerarsi concluso (secondo il significato piú diffuso del titolo, che equivale “all’Amèn ebraico”); e – dall’altra – in accordo a un’accezione per l’appunto biblica, che quel che scrive “È vero”. Ciò che di critico (ermeneuticamente inteso) sulla sua poesia mi sento di affermare, l’ho già espresso in diverse e disparate occasioni (…) ma la novità di questo E cosí sia è l’intervista che il sé stesso lettore propone al sé stesso poeta alla fine del libro: una preziosissima dichiarazione di poetica (e di politica culturale), quale mai in precedenza l’autore modenese si era concesso, in piena sintonia con l’“intervista immaginaria” Intenzioni, che Eugenio Montale aveva pubblicato nel gennaio 1946. (…) Resta che E cosí sia – l’ultimo o no del suo autore – è un libro teso e calibratissimo, da leggere e assaporare con la medesima adesione richiesta (per complessità, profondità e pathos) da un autentico Trovatore dell’epoca nostra.
Enrico Trebbi è nato a Modena, dove risiede, nel 1953. Ha pubblicato alcune plaquettes di poesia insieme ad Alberto Bertoni. Sue poesie compaiono in diverse riviste ed è presente con proprie sezioni in antologie collettive.
Insieme ad Alberto Bertoni e al saxofonista Ivan Valentini ha inoltre pubblicato 2 cd di poesie e musica: “La Casa Azzurra” (Mobydick, 1997) e “Viaggi” (Arx Collana & Book Editore, 2001).
Nel 2020, con Bertoni, Valentini e la partecipazione del chitarrista e compositore Luca Perciballi, ha dato vita alla realizzazione del cd “Fumana” (2019 – poesie in dialetto modenese e musica), e dell’album “Intersezioni” (2022 – solo in formato digitale).
Ha inoltre pubblicato le raccolte di poesia: “Un resoconto frammentario” (Book Editore, 2003), finalista Premio nazionale di poesia San Pellegrino 2004, “L’incertezza del volo” (Book Editore, 2017), vincitore del Premio nazionale di poesia Caput Gauri 2018 e finalista Premio internazionale di poesia Gradiva 2019 – State University of New York, Stony Brook. Nel 2025, sempre con Book editore, “E così sia”.