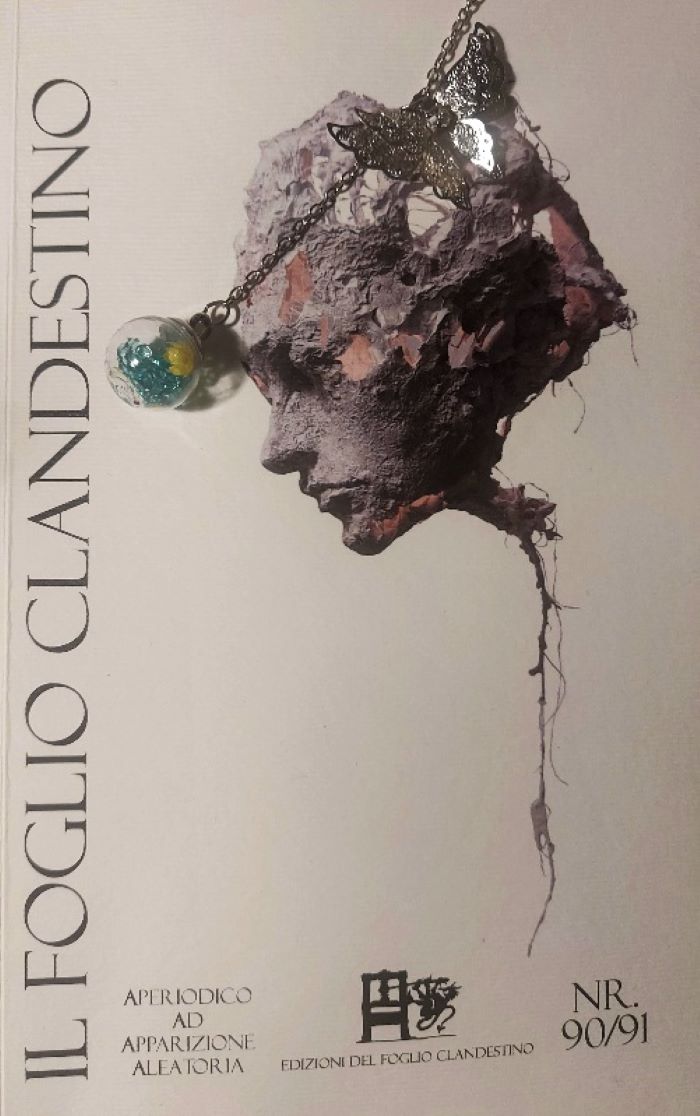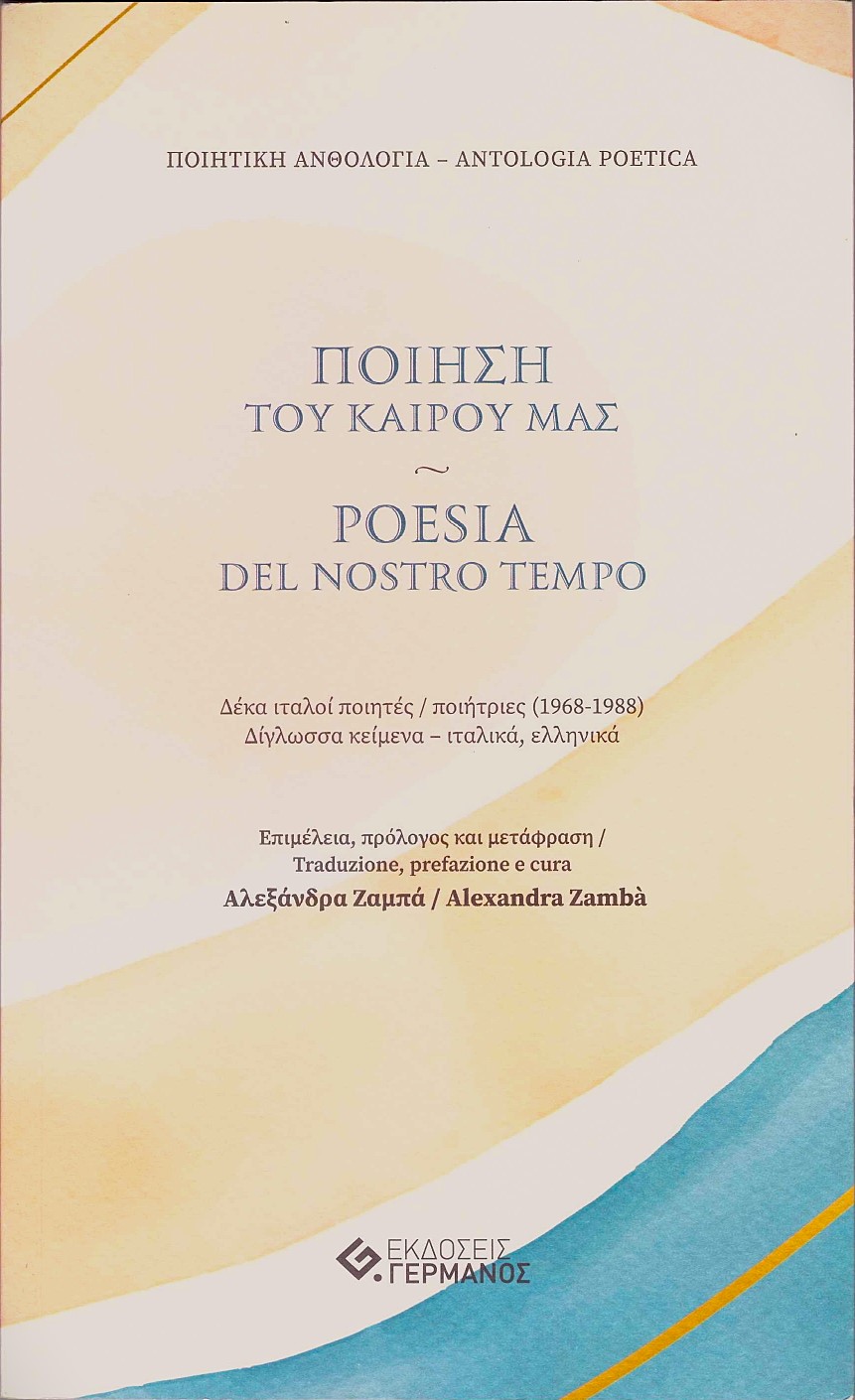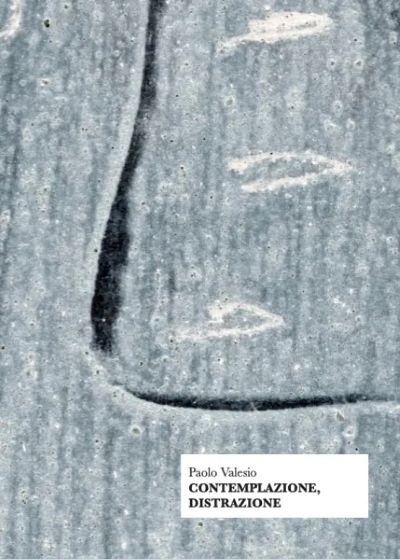a cura di Rosanna Frattaruolo
da Abitare un interrogativo
L‘ora delle formiche – dedicata a Ettore
Sognavo di essere un pittore –
di trasformare le cose infelici e bugiarde, che gravitavano
[come falene,
secondo le mie cicatrici
in un atto di speranza meno amara
per chi, come me,
fosse stato abortito dal proprio cordone ombelicale;
di trovare tra le pennellate, che bruciavano come il
[creato, il mio asse
con cui attraversare quella trincea
e, con essa, coniugare l’eclissi dei miei batticuori nella
[quale respiravo
in una casa da abitare.
Stretto a letto nella posizione di una sillaba di luna –
mani e piedi molli e muti –
perdevo lentamente l’approdo con il mio corpo ancora
[acerbo
per svegliarmi nell’infinito tra la fortuna e Dio;
pendulo dalle mie labbra
il mondo appariva confuso, inafferrabile, sconosciuto
dalle ombre in movimento e nervose
quasi delle piccole formiche nel cerchio di un’ora;
c’era un ricordo che resisteva come un fiore
in quella terra di mezzo
nuda come io ero nudo, e arsa dalla carne,
e mi aiutava ricomporre con le sue zolle il quadro
[imperfetto del mio nome.
Anche gli angeli dormivano
mentre le mie ossa si stringevano in un pentagramma
[d’inverno
la cui clessidra era una parola scomposta nel vuoto
e l’urgenza una malattia.
E io sognavo ancora, senza paura,
di diventare un pittore –
una pennellata era per sopravvivere
un’altra per salvarmi,
e la terza era per esistere nella cruna di una preghiera
mentre liquido il mio pensiero, ed evanescente, quasi
[un’aritmia d’amore, si faceva alba.
*
da Appendere il canto alle fragilità
Canto a mio padre
Come Dio nel creare gli animali e le piante.
Io canto e la montagna balla
Mio padre morì battezzato dall’inchino di un fulmine –
nella pancia stanca come l’alba quei versi
che non erano ancora germogliati,
la terra ad accoglierlo nel suo sudario di madre
mentre un vitello gli baciava gli occhi
da cui il cielo aveva estirpato, guancia a guancia, il cuore:
occhi umidi, e neri
come umido e nero è il buio dei fantasmi,
il sapore del vuoto.
Gli alberi si stringevano l’un l’altro in una canzone:
poteva essere una ninnananna
con cui dimenticare
o forse una preghiera inzuppata in un bicchiere di latte
per liberare l’attesa –
era una canzone che sapeva meno di guerra
e più di assenza,
come quando dentro, nel sangue,
dove tremuli ci nascondiamo,
sembra nevicare.
La nostra casa era stretta nel fianco di Dio –
tra fiori dalla forma di pugni, la pelle azzurra delle
[montagne
e il respiro degli orsi.
Dalle cime annodate alle nuvole come cavalli –
da dove le lepri portavano nomi
che non ricordavamo,
le encantades partorivano stelle fertili d’amore
che si trasformavano in aquile,
i lupi leggevano gli oroscopi nelle ombre dei rumori
e gli anni oziavano
in compagnia dei morti –
comparve nudo e senza eco un capriolo:
gli occhi muti, e neri
come mute e nere ritagliavamo le lune
quando giocavano a nascondiglio con le fronde.
Erano gli occhi di mio padre.
*
da Apostasie senza lancette
Eva ha due papà
È un istmo che salda due sogni d’uomo, Eva,
in un’ora d’acqua
indefinita come l’orizzonte,
nel suo aver bucato la parentesi di due vite in un cuore
e aver smosso zolle di preghiere
– terra dopo terra
sangue a sangue –
a forgiare molliche di carne in un corpo di donna,
dove l’ambra di un’alba esilia l’ombra
al nutrirsi instancabile di due api
della polpa che i grappoli penduli di un glicine
portano in grembo.
È il nome che si compie, Eva,
in una perfetta simmetria d’amore
dove tutte le variabili di due uomini combaciano,
nel suo aver tracciato la spuma congiunta di un’esistenza
e aver destato le lancette di un brivido
– cielo dopo cielo
miele a miele –
a liberare la radice di due semi in una nuvola d’argilla,
dove il vento accorda la sua voce d’arpa
al germogliare instancabile dei colori di Dio
che tingono il corpo al buio
di una notte d’airone.
È l’approdo di una magia esausta di silenzio e attesa,
[Eva,
morbido di rugiada
dall’odore della neve.
*
da "Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin?"
Il peso viola del coraggio (a Oscar Wao)
Erano lenti e stanchi, gli anni di Truijllo, scarni e senza
[benedición,
e ogni figlio dell’isola aveva una stella di fukú a
[seguitarlo
che nessuno osava scomporre in sillabe,
ancora meno nel sussurro di un sogno o di un amore,
per non scoprirsi cuore contro cuore in un campo di
[canna di zucchero
prima di aver avuto il tempo di decidere
a quale Santo votarsi.
Contavamo la polvere,
molti respiravano le proprie orme, incerte ed
[epidermiche,
e tessevano rimorsi,
qualcuno prestava il nome alle onde corte dell’Avana
per tentare il domani,
c’erano studenti, spesso figli di zapateros,
il cui incedere era lesto, quasi diafano, e d’ombra,
e tutti eravamo in attesa,
intrappolati nel grembo cavo di una terra, nostra madre,
dove il diablo seminava la sua gramigna,
l’ansia di sentire bussare alla porta,
una nota di merengue inghiottita dal silenzio di un padre
[che svaniva,
l’aria che si dissolveva,
e persino il vento ridotto all’accenno di un apostrofo.
La vita era una hjia dagli occhi di Atlantide, con un cuore
[in apocalisse,
forgiata dalla povertà primitiva quanto basta dell’Azua
[Profonda,
una parabola d’oscurità
che segnava il primo e ultimo neo del giorno
con o senza un amen,
dove la Fine del Mondo e la Mangusta
tanti scordatidimé nell’educazione di un esilio,
i c’erano una volta senza epilogo,
fukú e zafa, e tutto al peso viola del coraje, insieme,
indovinavano un’Anacaona moderna sulla iolla
verso una pagina bianca e innocente come questa.
*
da memorie da sotto l'orizzonte
Un bacio al mio ultimo desiderio – in
memoria di Matthew Sheppard
E adesso che sono legato a questa preghiera al contrario
[di legno
e mi affaccio senza ali sulla terra
che mi circonda nelle sue variazioni di semina
al centro di un grembo di ombre
e sento pulsare il cielo
dove la fronte forma un cuore, nudo
nel mio nome, con l’infinito a fare da eco
e una sola stella a coprirmi,
assomiglio a un Cristo
a cui hanno negato il giardino e la spina,
inchiodato alla mezzanotte,
capovolti i ricordi,
l’asse che diventa abisso,
il respiro un giglio bianco che si congiunge
alla mia orma, scalza
nella fragilità con cui il gesto presagisce
brividi che alternano stagioni,
la gola serrata dalla promessa di falce,
le costole che premono come se volessero espellere il
[sangue
e insieme la vita da questo corpo
che si lascia martoriare
e brucia come brucia il roveto della notte
quando tacciono i sogni
il mondo divorato negli occhi chiusi dei miei polsi.
Offrirò gigli rossi che raccontano storie ai miei fratelli,
fantasmi che cercano ancora amore
offrirò poesie nelle quali gli angeli in coro diventano
[carne,
bocche dalle quali nevica l’azzurro delle rondini
offrirò un bacio al mio ultimo desiderio
tra polline di vento che migra, in silenzio
senza un’alba, senza un addio.
Dalla postfazione di Gianni Antonio Palumbo.
[…[ La sua poesia sembra figlia del paradosso di un duplice radicamento bilanciato da un altrettanto intenso e profondo eradicamento. I suoi versi traggono linfa, infatti, dalla dimensione della storia di un genere umano che sembra aver smarrito le sue insegne e crocifigge gli angeli cui è toccata la stimmata della non conformità alla massa. L’immanitas semina violenza e morte come fossero “gigli rossi” e il destino può essere in agguato per chiunque; si legga in tal senso Autobus trentasette (2 agosto 1980), riferita alla strage di Bologna e alle dolenti corse dell’autobus che n’è divenuto un simbolo. […] È una poesia in cui si può persino avvertire l’odore della pelle (ma anche del sole della neve del sangue) così come il tanfo delle prigioni in cui si consumano agonie silenziose. Il verso a tratti si dilata facendosi narrazione;
rifugge la cantabilità ma ha una sua musica tutta interiore, che il lettore attento avverte distintamente. Le immagini germinano le une dalle altre, mai scontate; alcune si imprimono nella memoria, come questa: “offrirò poesie nelle quali gli angeli in coro diventano carne, / bocche dalle quali nevica l’azzurro delle rondini”. Qui si avverte la tendenza di Colacrai a materiare il disincarnato e spiritualizzare la materia, perché è la condizione stessa di “ossimoro” vivente, che connota la voce del poeta come le voci con cui si gemella, a favorire tale processo. Se questa silloge – alle porte dell’autunno – ci inchioda alle tante croci di cui ignoriamo l’esistenza – e da cui molti non si sentono toccati – la sua è anche una poesia in cui percepisci la
forza della speranza, nell’auspicio che ci siano figure come quel padre-professore quasi sulla soglia della raccolta, “con il coraggio che bruciava come un’instancabile stella cometa” […].
Giurista e Criminologo, Davide Rocco Colacrai partecipa da quindici anni ai Concorsi Letterari e ha conseguiti oltre mille riconoscimenti, anche internazionali, tra i quali quattro Premi alla Carriera, un Premio al Merito Culturale e la Medaglia del Presidente della Repubblica.
“Ritratto del poeta in autunno” (Le Mezzelane) è il suo undicesimo libro di poesia.
Hanno scritto di lui Alfredo Rienzi, Carmelo Consoli, Livia de Pietro, Armando Saveriano, Italo Bonassi, Flavio Nimpo, Mauro Montacchiesi, Gordiano Lupi, Alfredo Pasolino, Stefano Zangheri e molti altri.
Sue poesie sono state tradotte in tedesco, francese, inglese, spagnolo, cinese, russo, albanese, turco, montenegrino e in lingua bengali.
Nel tempo libero, studia arpa, colleziona 45 giri da tutto il mondo (ne possiede oltre duemila), ama leggere, fare lunghe passeggiate con il suo cane Manny e viaggiare.
Per Le Mezzelane Casa Editrice ha pubblicato le sillogi “Instantanee donna” (2017), “Asintoti e altre storie in grammi” (2019) ,“Della stessa sostanza dei padri” (2021) e “D come Davide. Storia di plurali al singolare” (2023)