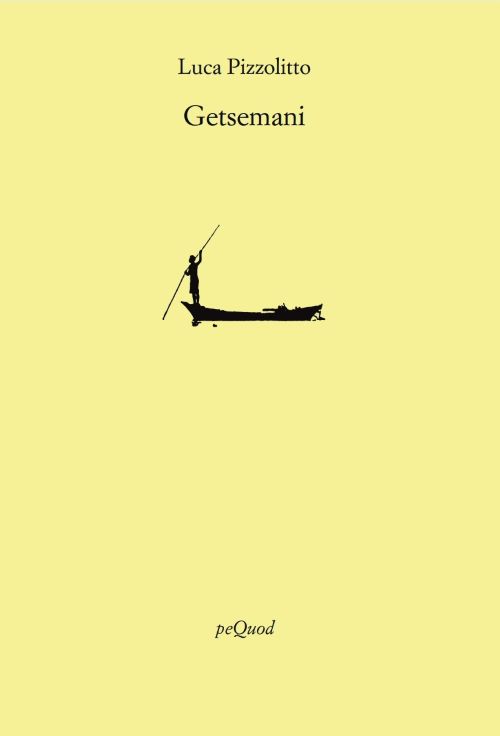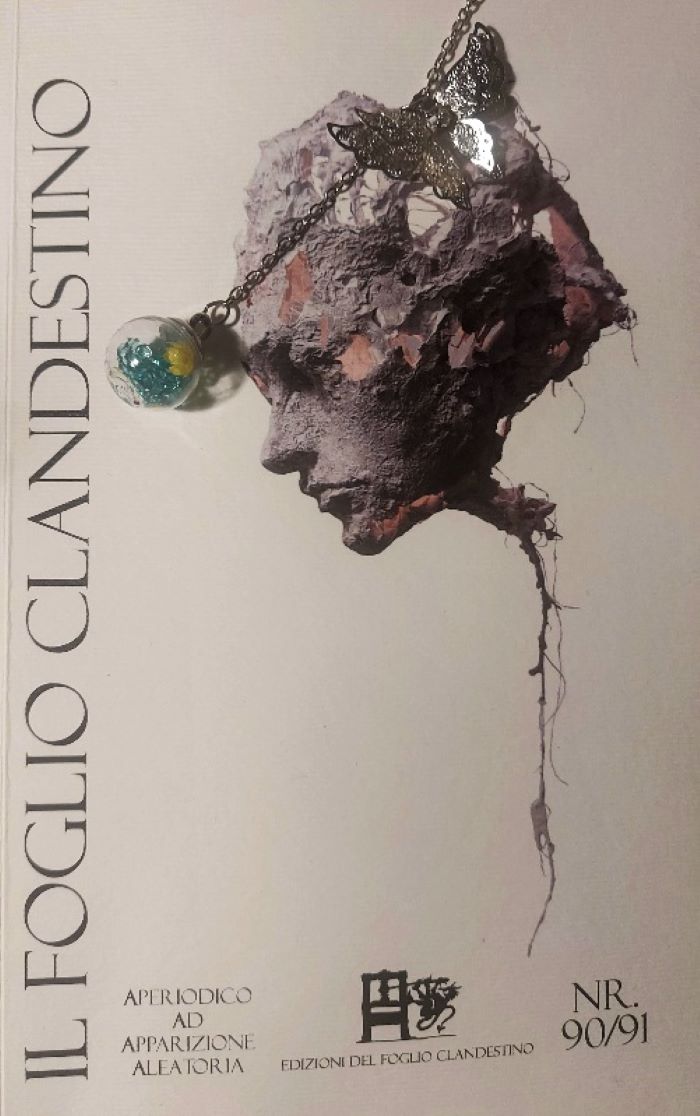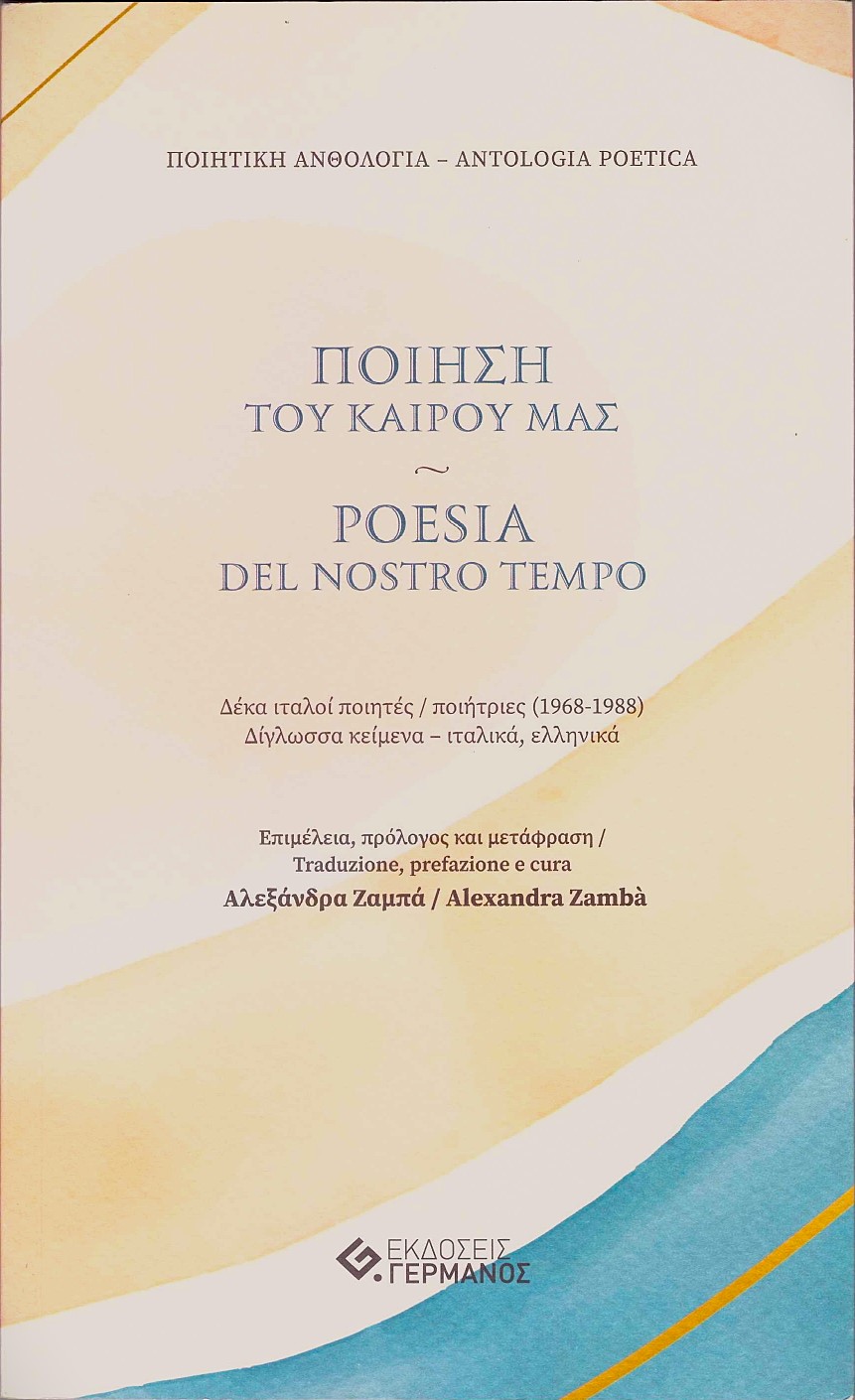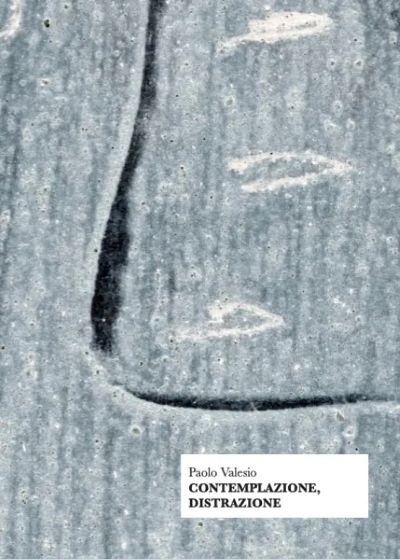di Stefania La Via
Getsemani, ultimo tassello di un’ideale trilogia poetica, a firma di Luca Pizzolitto. Opera essenziale, quasi francescana, in cui i versi si aggrumano nel bianco della pagina in brevi distici, in terzine o quartine; talvolta un verso singolo sembra galleggiare nello spazio, la parola emerge dal vuoto che la circonda, incide forme di suono e di senso, si fa preghiera laica, intrisa di spiritualità.
Nella sera oscura della tentazione, della prova, in limina mundi, l’anima oscilla tra l’accettazione e la tentazione del sottrarsi. La lingua si fa spazio concreto, materia di densa concentrazione, alternanza di luci e ombre. La difficile, umana fragilità diventa scelta di senso, soglia da attraversare, passo da compiere in solitudine prima di varcare l’abisso in cui «non esiste parola» Sulla scia di quanto suggerito dai titoli delle precedenti raccolte (Il tempo fertile della solitudine; La nuda vita; L’allontanarsi delle cose), Pizzolitto guida il lettore in un solitario cammino di spoliazione, sino al giardino dell’estrema solitudine, della scelta di posizione definitiva che si colloca al confine fra il tempo e l’eterno, in un silenzio gravido di tensione religiosa.
I versi e le parole in corsivo, disseminati tra i vari testi, sembrano suggerire una sorta di salmo nascosto, ritmo nel ritmo, respiro che si mescola a quello dei versi.
Cosa resta dei giorni che si consumano, della condanna del vivere, sembra chiedersi e chiederci Pizzolitto? Solo la sete di senso, i volti di chi abbiamo amato e di chi ci ha amato, immagini che scolorano eppure persistono, tra «breve memoria» ed «eternità di luce».
Nell’eterno l’assenza pesa, si fa impossibilità del dire, del comprendere, trasformandosi in ricerca, in «braccia spalancate» nell’afferrare il vuoto ed, infine, in accettazione, resa che è «fatica», sofferenza per la «fine immatura del giorno». Eppure dalla dimensione dell’eterno la vita non è tagliata fuori ma emerge prepotente nel ciclo delle stagioni, negli oggetti della quotidianità, nei fiori, nel vento, nella musica, nell’«inquieto stare»: nel dramma dei «cinque corpi a riva / sputati dal mare».
Il dialogo tra umano e divino è dialogo tra un io che vive l’attesa e un tu che si fa «permanenza, stasi, dimora». La sete di un senso all’andare è sete del divino, di un’agognata salvezza che appare ancora troppo distante, quasi irraggiungibile dalla prospettiva del nostro individuale Getsemani.
Dall’orto degli Ulivi, giardino sofferto della scelta e dell’attesa, «nessuno torna innocente», ci ricorda il poeta, che non soffre solo per sé ma ha, nel proprio destino, il soffrire «per il nostro umano non restare», per il morire «nel deserto delle cose», mantenendo tuttavia la capacità di ritrovare «le stanze dimenticate / della gioia», «l’antico fiore / del canto» e di mutare la sete di umano in sete di Dio.
Attorno al vuoto, alle assenze, la voce poetica costruisce la propria geografia immaginifica. Il silenzio come distanza «da me, / da tutte le cose»: i silenzi della meditazione, della riflessione o della preghiera, sono la cifra della raccolta; un tacere fecondo che potenzia lo sguardo, che è fatto di desta attenzione ai dettagli. La «parola taciuta» si trasforma in pensiero, ritrova la «misura perduta delle carezze», la cifra segreta, «il senso smarrito» delle piccole cose che intessono il vivere quotidiano. È il lasciarsi sorprendere dall’inatteso, nel tempo delle certezze e degli assolutismi.
Il dubbio impone il fermarsi, impone la riflessione e la scelta, spesso inevitabile e dolorosa. Il sottoporsi alle prove della vita, l’accettare un destino possono essere forieri di transizioni, di cambiamenti. Bisogna abbandonare le sicurezze presunte, lasciare andare, saper cercare nuove strade da percorrere. Si aprono immense possibilità di guardare al mondo e a se stessi con altri occhi, da altre feritoie.
Attraversando tra resistenza e resa l’ora buia del Getsemani, il silenzio dell’assenza, del rifiuto, dell’abbandono, approdo del viaggio sarà un non luogo «da cui non si parte / né arriva», «Dio, spazio d’eterna resa», e allora, oltre la soglia stretta della contemplazione, ci sarà «solo bellezza», che sboccerà inattesa, come fiore che nasce dalle spine.
Il parto avaro della notte
mastica e sputa la displasia
del giorno, separi il respiro
in due acque.
I cieli divisi della tua fame.
Nell’abisso, nel vuoto
non esiste parola
***
Erba amara, fatica è la resa
incondizionata a Dio
bellezza che volge in pietra,
morire oggi nel deserto delle
cose, la fine immatura del giorno
– mia vita, mia vita involontaria.
***
Spina di cardo
bianco costato
folle perdono
del sangue
– mio padre
è cieco,
traccia la via
solo col canto.
***
Luglio qui si attende
nelle crepe.
Scrivere è il mio
secondo esilio.
Luca Pizzolitto nasce a Torino il 12 febbraio 1980, città dove attualmente vive e lavora come educatore professionale.
Da più di vent’anni si interessa ed occupa di poesia.
Tra i suoi libri, figurano: Dove non sono mai stato (Campanotto), Il tempo fertile della solitudine (Campanotto), Tornando a casa (Puntoacapo).
Con la casa editrice peQuod ha pubblicato, nella collana Rive: La ragione della polvere (2020), Crocevia dei cammini (2022), Getsemani (2023, prefazione di Roberto Deidier).
Nel 2023, è stato inserito all’interno dell’antologia Nord i poeti, vol. II, edita da Macabor.
Da fine 2021 dirige la collana di poesia Portosepolto, sempre per conto della casa editrice peQuod.
È ideatore e redattore del blog poetico “Bottega Portosepolto”.
Cura la rubrica Discreto sguardo per la rivista on line “Poesia del nostro tempo”, Nostos – ritorno alla parola per il blog L’Estroverso, Polaroid – istantanee di poesia per FaraPoesia.