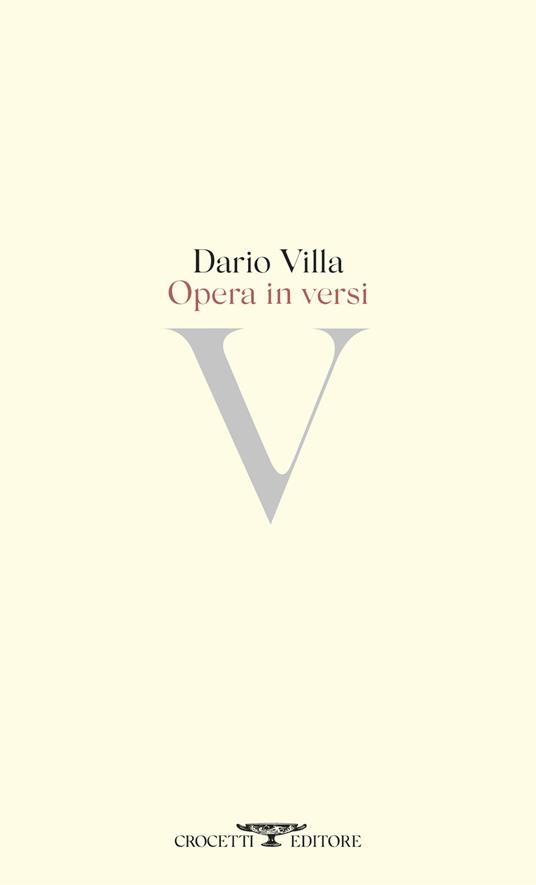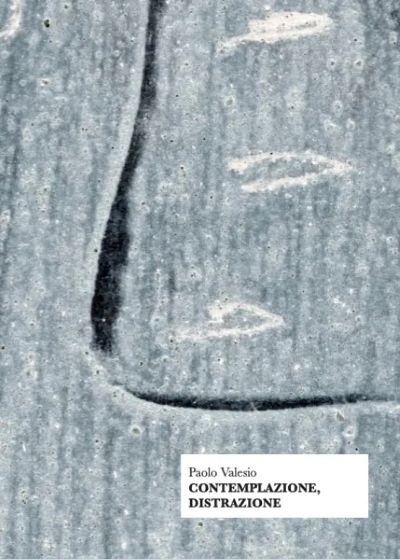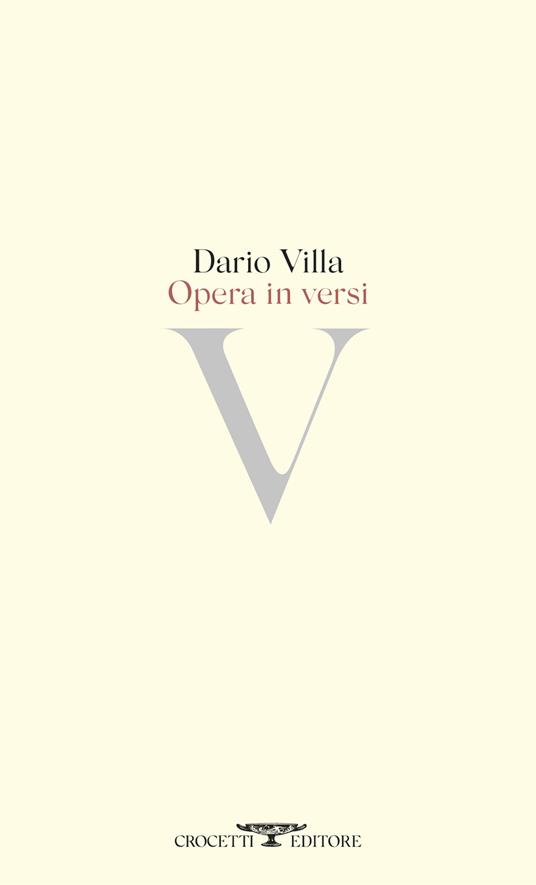
OPERA IN VERSI è la raccolta firmata Dario Villa, edita da Crocetti Editore (2025). Opera in versi appartiene certamente alla categoria delle opere che vanno “ricollocate”. Non perché sia un’opera “difficile” in senso tecnico, ma perché mette in crisi, fin dalle prime pagine, l’idea stessa di cosa significhi oggi attraversare un’antologia e, soprattutto, di come si costruisca una genealogia poetica senza trasformarla in monumento. Trattandosi di una raccolta che attraversa differenti periodi, andrebbe letta come una sorta di autoritratto involontario: ciò che emerge è la persistenza di una voce.
La prefazione di Alessandro Giammei lo dichiara apertamente: questo volume non è un’operazione celebrativa, ma un gesto di giustizia critica. La citazione iniziale di Patrizia Valduga — “per giustizia, si riscriva la storia” — non funziona come epigrafe autorevole, bensì come mandato. Il libro chiede di essere letto come un volume che agisce retroattivamente, non aggiunge una voce al coro, ma obbliga a riascoltare l’intonazione complessiva del tardo Novecento poetico italiano.
Difficile inquadrare Villa in una scuola di pensiero o poetica di appartenenza, dalle letture su questo autore emerge l’idea di “un errore di sistema”. Non perché eccentrico, ma perché fuori asse. Come osservava Raboni, la sua poesia sembra stare sempre “un passo avanti, un po’ altrove”. Non fuori dalla tradizione, ma in posizione obliqua rispetto ad essa. La sua marginalità non è periferica: è strutturale, frutto di una scelta di postura. Il prefatore Giammei lo definisce “amichevolmente equidistante” dalle tendenze del suo tempo: è insieme tradizionalista e sperimentatore, pacato e ribelle, innamorato dei classici ma refrattario al canone. Non distrugge la forma, ma cerca di forzarla o piegarla. Questa singolare collocazione deriva anche dalla sua lunga pratica della traduzione, che ha radicato la sua scrittura in una cosciente tecnica della lingua. Villa non è poeta dell’ispirazione, ma della costruzione.
La sua abilità emerge nel modo in cui tiene insieme registri inconciliabili. In una poesia esemplare, la comprensione metafisica del vuoto nasce aprendo un frigorifero: “le architetture deserte del vuoto” convivono con “epigrafi straniere a iosa scritte sotto la foto di un prodotto”, fino a intravedere “l’omino di Chagall, col suo violino”, subito smentito da “una lattina di tonno in un punto della navata laterale”. Il sublime non viene negato piuttosto messo in cortocircuito con il reale. È in questa frizione che si produce conoscenza. Anche sul piano formale, Villa è poeta della lingua prima che dell’io. Versi come “Sto male, male; sto / bemolle, desto, stressato” mostrano come la musica interna non accompagni il senso, ma lo generi. L’ironia non è decorativa ma arriva precisa. Nei testi più riflessivi la poesia diventa un’indagine sulla percezione stessa: “lo spettro delle percezioni / si riorganizza, a scatti”. Il mondo non è dato, ma continuamente ricostruito.
Questa capacità di tenere insieme rigore e scarto rende Villa una figura anomala del Novecento poetico e difficilmente viene collocato in correnti o famiglie. La sua scrittura non consola, tende a chiarire; non cerca di pacificare il reale ma lo rende leggibile. Rileggendo tutte le sue opere, risulta sorprendentemente attuale. In un tempo segnato dal ritorno al sentimentalismo, la lezione di Villa – fedeltà alla complessità, diffidenza verso ogni pacificazione lirica – è una sorta di antidoto. Opera in versi non colma solo una lacuna storica: rimette in circolazione una forma di intelligenza poetica che non si limita a dire sul mondo, ma lo misura.
Nota di lettura a cura di Antonio Corona.
Estratti da OPERA IN VERSI
da ARCHITETTURA, PITTURA, FOTOGRAFIA
Il terzo giorno ho inventato sapori
ossuti come un disegno di Schiele.
Aprendo il frigorifero ho compreso
le architetture deserte del vuoto.
Stranito dalla fame, percorrendo
stradine dove gli uomini erano altri,
ho letto epigrafi straniere a iosa
scritte sotto la foto di un prodotto.
Tra i pinnacoli in cima alla città
di un duomo tardo gotico, ravvolto
in un kaftano sbiadito, ho intravisto
l’omino di Chagall, col suo violino.
Forse era meglio scendere. Incontrare
una lattina di tonno in un punto
della navata laterale, in fondo,
mi era parso possibile. Che errore.
*
da L’ALA DELL’IMBECILLITA’
o ramarro del senso
disperso a larghe mani
dalle seminatrici d’inquietudine
sulla scia blu di rospi favolosi
io sulla bava d’iride
delle strianti spiraliche
molli lumache perse e arrampicate
sull’avambraccio biforcuto che
germoglia ad elice
io la gola del morto
che gorgoglia d’orgoglio e d’orologi
fermi all’incrocio del minuto esatto
con il quadrante sbagliato
io o i malrecapitati ordini del tempo
rebis rebis che s’incupisce al ricordo
concupiscente-rubino d’un passato gotico
e flamboyant di boccali-pinnacolo e
accesa frambogia
io ripreso a ritroso
dalle moviole e proiettato dal Cameraman
su schermi palingenetici e dietro
ribalte d’amnio fino al seme del padre e di dio
io che in fondo non dubito
dell’esistenza dell’uomo ma slitto
fino al no più crudele sulle rose infrarosse
che pavimentano il soffitto e il bosco
io che distratto ho percezioni
nitide della frusta del fogliame come
se applicassi una lente alla mia nuca
e vedessi i capelli dell’urone che cova il taglio
io chelidro e farea
e iaculo al centro del verbum dimissum
nutrito dai rituali midolli di chi
se l’è cavata per un passo falso
io perché in fondo tu mi fai notare
voi benché lui non abbia ormai con noi
più relazione essendo entrato in loro
mentre il ramarro nega i tre serpenti
io che tra l’altro non per farmi bello
mangio coda e pavone pisciando l’oro
nel becco della fenice ogni mezzo millennio
e finalmente tra le righe lego
l’ego in lalia di sdoppiato narciso
e con il Nirvanìl so divenire
sogno che pulsa sguardo pullulante
nel nirvana del traffico beffardo
ego eretico scriptor mago argotico
strego che strega frugole di fragola
castrato in fregola nero albigese
che erige il rogo a regola dell’ego
*
da IN LIMINE
è più simile a me
l’ombra che resta in piedi quando cado
di quanto non sia io
tanto più umano
così staccato da me
con la mano tuffata tra due rive di sete
dove non scorre che un’idea del tempo
scaturita da un altro e bevuta da tutti
oggi la casa ha l’ordine delle finestre
l’inclinazione del tetto
la teoria delle stanze
la porta interiorizzata
la domanda del letto e gli orologi famosi
la vita ha ritmi sinuosi
come i languori di una donna
tatuata dal solco in questo o in altro
senso che si rovescia
dove piove l’onda
dove naufraga pieno
di spinose speranze
il pesce elaborato dall’abisso
dove se non c’è acqua se nient’altro preme
profondità superficie
la politica esula dall’interesse dei morti
peccato sarei stato un buon fantasma
un tantalo intontito sull’orlo della vasca
*
Dalla prefazione di Alessandro Giammei
“Per giustizia, si riscriva la storia di quest’ultimo decennio, si ridistribuiscano glorie, premi e apprezzamenti, e dalla folla dove tanti fasulli e stonati si vorrebbero poeti a dispetto degli uomini, degli dèi e dei chioschi di librai (e ingombrano le gazzette e persino gli schermi) si estraggano i pochi veri poeti, e tra questi Villa sia riconosciuto il migliore, subito”. Così, verso la fine del millennio scorso, tuonava Patrizia Valduga dalle pagine del Corriere della Sera, presagendo la prematura scomparsa dell’autore la cui opera in versi è finalmente restituita al pubblico della poesia con questo libro. Si tratta di un poeta che rimase amichevolmente equidistante da tutte le tendenze letterarie del quarto di secolo che attraversò scrivendo, flâneur timido e sfacciato, lungo il malinconico tramonto dilungato della modernità; un visitatore angelico delle modeste rovine della Storia che Milano ancora non seppelliva tra la fine della guerra in Vietnam e l’inizio di quella nel Golfo. Si tratta di un pacato ribelle sornione, di un tradizionalista estraneo al canone, di uno sperimentatore innamorato dei classici: di colui che Giovanni Raboni definì “il migliore, il più veridico seguace di sé stesso”, animato com’era dall’irriducibile, euforicamente tragica ironia cui lo costringeva quella che Tiziano Rossi chiamò “la consapevolezza del proprio esercizio e funambolismo”. […]
È un volume dedicato a chi ancora crede che il tardo Novecento italiano, così ricco di poesia inclassificabile e così sorprendentemente capace di chiamare per nome i traumi rimossi su cui si fonda il nostro tempo, abbia molto da dire a coloro che, come me, sono nati troppo tardi per guardarlo con l’incantevole disincanto di Dario Villa. Per volere di Marta Pellis e Ginevra Villa, è un regalo a chi ha il coraggio di canticchiare “erano tempi allegri / gli anni di piombo”, consapevole che l’ironia è il più efficace dei contravveleni in un’età nostalgica come la nostra.
Dario Villa è nato nel 1953 a Milano, dove ha vissuto e lavorato fino alla sua scomparsa, nel 1996. Ha esordito a metà degli anni ottanta con Lapsus in fabula, che gli è valso il premio Mondello Opera prima per la poesia. Oltre all’attività poetica, proseguita con numerose plaquette e con il libro Abiti insolubili del 1995, si è distinto come traduttore dall’inglese e dal francese – tra gli altri, di Isherwood, Bunting, Blake, Rimbaud – collaborando con case editrici come Guanda e Mondadori. Nel 2001, Seniorservice Books ha pubblicato l’autoantologia postuma Tutte le poesie 1971-1994, a cura di Katia Bagnoli e con prefazione di Giovanni Raboni.